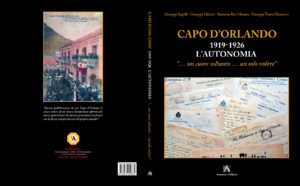La “Triplice cinta” di Castania, al di là dell’etimo e della storia.
di Giuseppe Ingrillì
 Esisteva un luogo di vita sui Nebrodi che oggi non è più vita, ma ricordo e muto testimone di chi in queste terre abitò. Questo luogo è Castania, sublimazione storica sospesa tra la nebbia di una memoria lontana e il presente vissuto in un toponimo che racconta un dramma. Le pietre a Castania parlano, per i suoi vicoli, nei muri e per le strade, ma l’ascolto non è ricevuto dalle orecchie; è l’occhio che vede, riconosce, reagisce e si sofferma nell’immaginare ciò che è andato perduto. Un ambiente reale, che vive nel virtuale, aggrappato ad una memoria da non perdere nell’angoscia che rinasce ogni volta che si ritorna. Oggi Castania si racconta attraverso i ruderi e i campanili, che sono la silenziosa testimonianza di una speranza andata perduta.
Esisteva un luogo di vita sui Nebrodi che oggi non è più vita, ma ricordo e muto testimone di chi in queste terre abitò. Questo luogo è Castania, sublimazione storica sospesa tra la nebbia di una memoria lontana e il presente vissuto in un toponimo che racconta un dramma. Le pietre a Castania parlano, per i suoi vicoli, nei muri e per le strade, ma l’ascolto non è ricevuto dalle orecchie; è l’occhio che vede, riconosce, reagisce e si sofferma nell’immaginare ciò che è andato perduto. Un ambiente reale, che vive nel virtuale, aggrappato ad una memoria da non perdere nell’angoscia che rinasce ogni volta che si ritorna. Oggi Castania si racconta attraverso i ruderi e i campanili, che sono la silenziosa testimonianza di una speranza andata perduta.
Castania è un punto interrogativo, una presenza che sbiadisce nella storia, che però oltre la furia della natura si scontra anche con la violenza distruttrice dell’uomo.
Esempio di tutto questo è la chiesa di Santa Maria di Mallimachi, che affonda le sue radici nel passato basiliano di questi luoghi e che diventa nucleo generativo restituito alla memoria da poche, sgranate o sbiadite immagini, che rendono parzialmente l’idea di qualcosa di diverso e di più prezioso, di monumentale e al tempo stesso sacro ed enigmatico, una presenza di gusto artistico diverso nell’arte nebrodense.
Oggi di questa chiesa sopravvivono qua e là solo pochi brandelli d’arte, sparsi per le campagne o incassati nei muri, negli stipiti delle porte, negli intradossi degli archi -chi ha potuto se ne è impossessato – come una preziosa reliquia da conservare con deferenza in un’eco da ultimo rispetto. Oggi Castania è nei suoi campanili: quello della chiesa di Santa Barbara (faro maiolicato del XIII sec. che attira il visitatore) e quello della chiesa dedicata a San Vincenzo Ferreri domenicano (del XIV sec., che qui si fonde in un monumento e sfogo religioso nell’idea di ciò che si è perso, mutilato dalle frane, a silenzioso ricordo di una forza che manco Dio è stato in grado di salvare, ultima preghiera che non è servita a compiere il miracolo). Chiesa monumentale a tre navate, quasi fuori contesto, polo opposto a Santa Maria dei Mallimachi, risparmiata solo in parte dalla forza della natura. Lei sopravvive all’infausto evento, che ne risparmia la memoria e ne esalta la fragilità; luogo con una sua precisa connotazione ed un particolare che si coglie nella navata di destra, nel percorso sacro della Via Crucis, lì dove la pavimentazione si spezza e rompe l’omogenea cromia, marcando la strada lastricata di dolore nell’epilogo delle ultime stazioni. E’ qui che assume il colore funereo della notte e della simbolica vittoria della morte sulla vita che, straziata, volge al termine con la morte di Gesù nell’attesa della resurrezione: per l’uomo che la percorre è la porta che segna il passaggio attraverso la luce. Religioso rispetto o interpretazione teologica di un ordine come quello Domenicano, che ha rappresentato per la cristianità il braccio armato e il baluardo con cui proteggere nel tempo la moralità e la battaglia contro l’eresia, rimarcando con il nero quello che alcuni ritenevano non accaduto.
Poco più in la, nel non più centro, la piazza della “vucciria” e le sue ombre medievali, raccontate attraverso l’atmosfera che si manifesta nell’onirica scena, che diventa viva visione quando, guardando il buco della gogna o la pietra logorata dall’uso e appellata “balata du culu”, si immagina l’uomo che si macchiava di crimini violentemente sbattuto di terga. Aspetti esteriori di una vita quotidiana fatta di “necessità virtù” e di esemplari punizioni per chi sbagliava. Più lontano, a lambire l’abitato, scorgiamo il campanile della chiesa di S. Nicola, fondata nel XII secolo e ormai destinata ad un oblio lento e tormentoso, a guisa di una agonia senza fine.
Accade allora che rapiti dal contesto, dall’atmosfera del luogo, ci si imbatta in una pietra che non è semplice pietra, diversa nel linguaggio e che non ti aspetti. Sta lì riutilizzata dall’uomo che ricostruisce la memoria con rispetto, abbozzando i perimetri di un’esistenza civile andata perduta. E’qui che in quest’eco di memoria scopriamo l’impensabile, quello che fino ad oggi non è mai stato nascosto, ma esposto sempre in bella vista,il segno della “Triplice Cinta”, simbolo di un linguaggio criptico ben definito.
Che cosa rappresenta e cosa ci fa a Castania?
Il simbolo attraversa la storia, fin dal suo primo rinvenimento sotto forma di pittura rupestre (13.000-12.000 a. C.) su pietre o massi verticali sui Monti Lessini in Veneto, in Friuli Venezia-Giulia o in Piemonte per rimanere in Italia. Lo stesso segno fu per i druidi e le popolazioni Celtiche caratterizzazione dei luoghi sacri dove riunirsi per celebrare i loro riti, per poi essere annotato più volte come simbolo presente sull’Acropoli d’Atene e per finire a Roma nel chiostro di S. Paolo nel XIII secolo. Acquisisce maggiore attenzione quando lo stesso simbolo viene ritrovato nel primo gruppo di graffiti nel castello di Chinon, prigione degli ultimi cavalieri templari e del loro Gran Maestro Jacques de Molay. Ad essi e al loro gnosticismo iniziatico, viene attribuita la paternità medievale e la diffusione del “criptico messaggio” a caratterizzazione dei loro ambiti.
Diventa per l’Ordine, la rappresentazione della Gerusalemme celeste, il percorso o il labirinto che l’uomo compiva sulla terra per arrivare alla sua destinazione finale. Ne viene esaltata la rappresentazione e allo stesso tempo sigillato in un concetto non accessibile, non alla portata di tutti, ma riconoscibile solo per chi aveva le necessarie chiavi interpretative. Tre sono i livelli disponibili per l’accesso o l’accettazione: quello superiore era solo per chi dimostrava capacità e livelli di conoscenza o di illuminazione tali da permettere l’accesso a verità sublimi. Il simbolo è ambivalente, diventa codice e portatore di un significato che assume varie forme; che sia cerchio tripartito o quadrato, è sempre riconducibile allo stesso significato di base, diventando simbolo universale che non è legato ad un luogo ma si identifica in una corrente.
L’interpretazione cristiana è semplice. Il quadrato magico è la rappresentazione della terra, che racchiude un quadrato più piccolo e poi un terzo quadrato ancora più piccolo a focalizzare l’attenzione su uno spazio minimo, sacro, un naòs o cella sacra, su cui si concentra lo sguardo, tutto messo in comunicazione da quattro linee ad angolo retto. La tripartizione segue la metafisica medievale: il Mondo Terrestre, il Mondo Firmamentale ed il Mondo Celeste. Congiungendo le quattro linee otteniamo la croce che, collegando e sovrapponendosi ai tre livelli, ci rappresenta nel punto centrale il luogo sacro, generativo, dove dimora Dio e dov’è la fonte.
Tanti si sono interrogati sulla penetrazione del significato più profondo o esoterico. L’errore è considerarlo come abbiamo visto un solo segno cristiano, ritrovandocelo anche in molte dottrine tradizionali orientali; per la sua triplice composizione si giungeva a considerare i tre quadrati come i tre gradi d’iniziazione, con le linee che diventano i canali entro cui far scorrere l’insegnamento. Una scala gerarchica che da un livello superiore trasmetteva ai livelli inferiori. Un pensiero ermetico, che collocava nella zona centrale la fonte d’insegnamento o “fonte del sapere”, tanto cara a Dante Alighieri e alla sfera di esoteristi noti come i “Fedeli d’Amore”.
Con la sua preponderante presenza in chiostri e in chiese nel periodo medievale, all’interno di spazi consacrati e in corrispondenza di luoghi considerati mistici, stava ad indicare la sacralità “tellurica” (del divino), oltre a marcare in un territorio la profonda connessione con le forze della terra e con quelle dell’acqua, l’elemento nascosto che faceva da catalizzatore ed amplificatore di energia. Era anche interpretata come una simbolica pietra miliare, posta lungo un percorso iniziatico che ne confermava la correttezza del viaggio, per giungere a quel luogo dove poter chiedere, poter osare, poter conoscere una sapienza non manifestata. E’ stato sempre considerato come l’omphalos (ombelico) che contrassegnava il centro di energie psichiche (telluriche, magnetiche e cosmiche), il punto in cui esistevano le premesse per la moltiplicazione delle energie mentali emesse da uomini in preghiera.
In questo, la trilogia muraria trova la sua ragione escatologica anche nell’ebraismo che, addirittura l’aveva applicata persino nell’assetto urbanistico: Gerusalemme veniva considerata quale onfalos tou kosmou(ombelico del mondo); il Tempio di Salomone (in seguito di David, Zorobabele e, infine, di Erode il Grande) quale ombelico dell’ombelico; il Sancta Sanctorum quale ombelico dell’ombelico dell’ombelico.
La pietra oggi, non è più nel suo contesto e non potremo mai ricollocarla, ma se ci soffermiamo almeno un po’ e, riflettendo, riportiamo alla nostra memoria le poche, sbiadite fotografie di Santa Maria dei Mallimachi tutto torna, si comprende e forse si capisce il luogo dove la sua collocazione era più naturale. Lì sarebbe stata nel centro generativo che oggi non c’è più, trasformato e riempito di sapienza nel corso della sua storia dimenticata, anch’essa ricordo e memoria di una diversa qualità, spirituale, teologica e gnostica, lì dove dimorava la “Sophia”. Ed è qui che ciò che non era è diventato, è qui che la storia ha voluto parlare il linguaggio della conoscenza.
Altre ricerche e approfondimenti ci attendono, ma se volete avvicinarvi per guardare nell’unico posto, oltre Castania in Sicilia, dove poterla vedere, dovrete andare a Palermo nel giardino della Cattedrale e ritrovare questo simbolo figlio oggi di un linguaggio muto: il resto sarà solo ricerca o il gioco di un momento.
Si ringraziano Calogero Prestileo memoria storica e competente accompagnatore e conoscitore dei luoghi a cui è intimamente legato e Michele Manfredi-Gigliotti per la revisione del testo e prezioso maestro di fine pensiero.